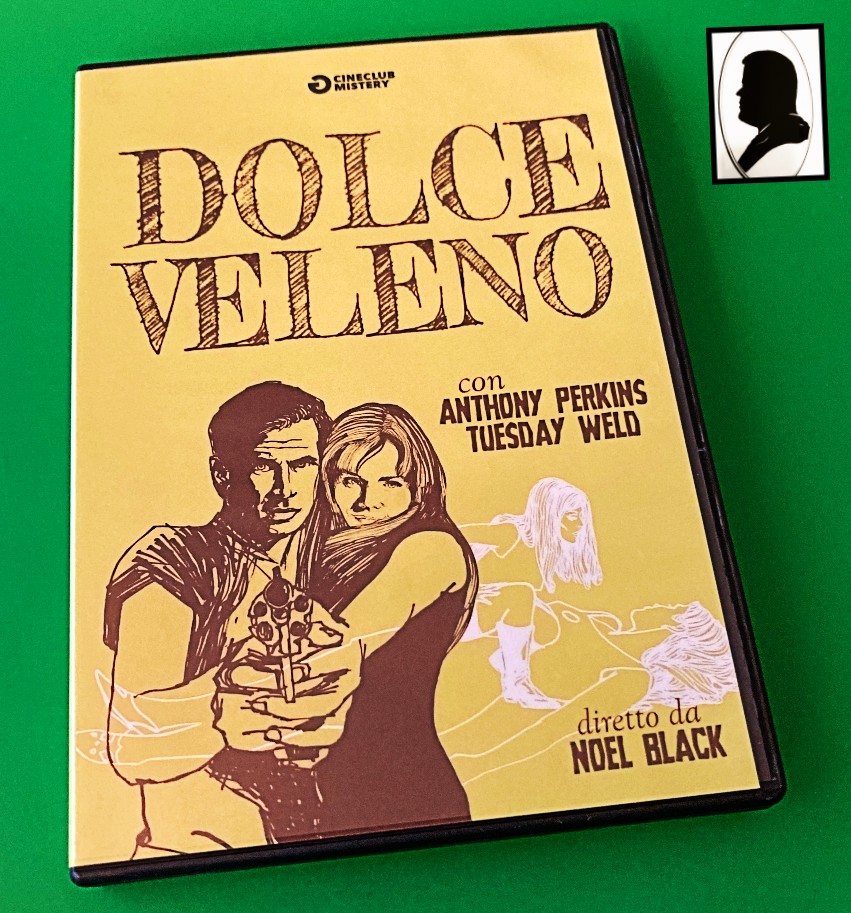(USA, 2022)
Primo adattamento dell’omonimo racconto “Il telefono del Signor Harrigan” di Stephen King, che apre la raccolta “Se scorre il sangue”, pubblicata dal Re nel 2020.
2003, in una cittadina del Maine il piccolo Craig ha dovuto accompagnare al cimitero – …suo malgrado – il feretro di sua madre prematuramente scomparsa. A tenergli la mano c’era suo padre con il quale, disperato, è tornato a casa.
Poco tempo dopo, dalla grande casa in cima alla collina dove finisce la strada in cui abita, arriva una singolare proposta. Il facoltoso signor Harrigan (un inquietante e sempre bravo Donald Sutherland), che da New York si è appena trasferito lì, avendo dei seri problemi di artrite alle mani e per assecondare la sua passione per la lettura, gli chiede di leggere per lui. Così, per pochi dollari all’ora, Craig inizia quasi ogni pomeriggio a salire fino a casa del Signor Harrigan per leggere ad alta voce.
Nei cinque anni trascorsi, Craig (Jeaden Martell, che partecipa anche alla nuova versione cinematografica di “It” del 2019) e Harrigan sono diventati amici e, fra un grande classico della letteratura mondiale e l’altro, si confrontano scambiandosi idee e riflessioni. Il ragazzo non riesce a comprendere come l’anziano posso rifiutare, nonostante i grandi mezzi, tutta la tecnologia che il progresso offre, non possedendo alcun televisore, ma solo una vecchia radio dove ascolta la sua tanto amata musica country.
Eppure, nella dimora di Harrigan, arrivano quotidianamente i più importanti giornali economici del Paese, e non solo, perché li suo ospite, ha scoperto Craig nel corso del tempo, è stato uno dei più scaltri e implacabili assi della finanza della Borsa di New York.
Siamo agli albori della rivoluzione che gli smartphone porteranno in tutto il globo che, in pochi anni, cambierà lo stile di vita di tutti noi. Anche Craig, quindi, anela il suo primo Iphone e quando il padre, per il suo compleanno gliene regala uno, si sente in paradiso. Vorrebbe condividere la sua gioia con Harrigan, ma l’anziano gli confida di essere molto scettico e prevenuto su questi nuovi “aggeggi”.
Fra le consuetudini di Harrigan c’è quella di regalare per le ricorrenze dei “gratta e vinci” alle persone che lavorano per lui, cosa che naturalmente comprende anche Craig. E proprio il “gratta e vinci” regalatogli consente a Craig di riscuotere 3.000 dollari. Con una parte della somma il ragazzo decide di regalare un Iphone ad Harrigan, che però ne rimane perplesso.
Solo quando Craig gli mostra come è possibile collegarsi in tempo reale col mondo là fuori, come per esempio con la Borsa di New York, l’asso della finanza cambia opinione. Negli incontri successivi Harrigan, che ha preso sempre più dimestichezza con il suo cellulare, confida al giovane tutte le sue perplessità sugli smartphone, oggetti che in mano alle persone sbagliate possono diventare davvero molto pericolosi. Craig, che reputa le riflessioni del suo anziano amico esagerate, sorride divertito.
Non troppo tempo dopo, un pomeriggio, il ragazzo trova l’anziano morto a causa di un attacco cardiaco nel suo salone, con in mano ancora il cellulare attivo. Craig deve affrontare così un nuovo lutto, e nel momento dell’ultimo saluto, senza che nessuno lo veda, per calmare il suo dolore infila nella tasca della giacca con cui l’anziano è stato vestito il cellulare che gli ha regalato, acceso.
Passano i giorni e il ragazzo scopre che Harrigan gli ha lasciato un lauto fondo fiduciario per consentirgli di fare tranquillamente l’università. Ma la sicurezza economica a volte non basta a tutelare dagli eventi più duri e spiacevoli che la vita ci riserva. Così Craig deve affrontare da solo il bullismo violento di Kenny Yankovich (Cyrus Arnold), irrisolto e scostante compagno di scuola che è convinto che sia stato lui ad informare i professori della sua attività di spacciatore.
Dolorante e preso dallo sconforto, Craig fa il numero di Harrigan che incredibilmente trova attivo, nonostante l’uomo sia stato seppellito già da qualche tempo. Quando parte la segreteria gli lascia istintivamente un messaggio raccontandogli le violenze di Yankovich.
Il giorno dopo Craig viene informato che il suo aguzzino è morto cadendo violentemente a terra, mentre tentava di scappare di casa…
Con una sceneggiatura, scritta dallo stesso Hancock, questa pellicola riporta in maniera quasi integra il suo spirito graffiante e angosciante del racconto originale. Così come lo scritto di King, anche questo film è un’ottima metafora dei pericoli che un uso sconsiderato, superficiale e aggressivo del cellulare – che in pochi istanti ci consente di collegarci al mondo intero – può provocare.
La pandemia e i fatti di cronaca quotidiani ci ricordano quanto questo aspetto oscuro del nostro cellulare sia reale. D’altronde, lo dice anche il grande Vasco Rossi: “Al diavolo non si vende …si regala”.