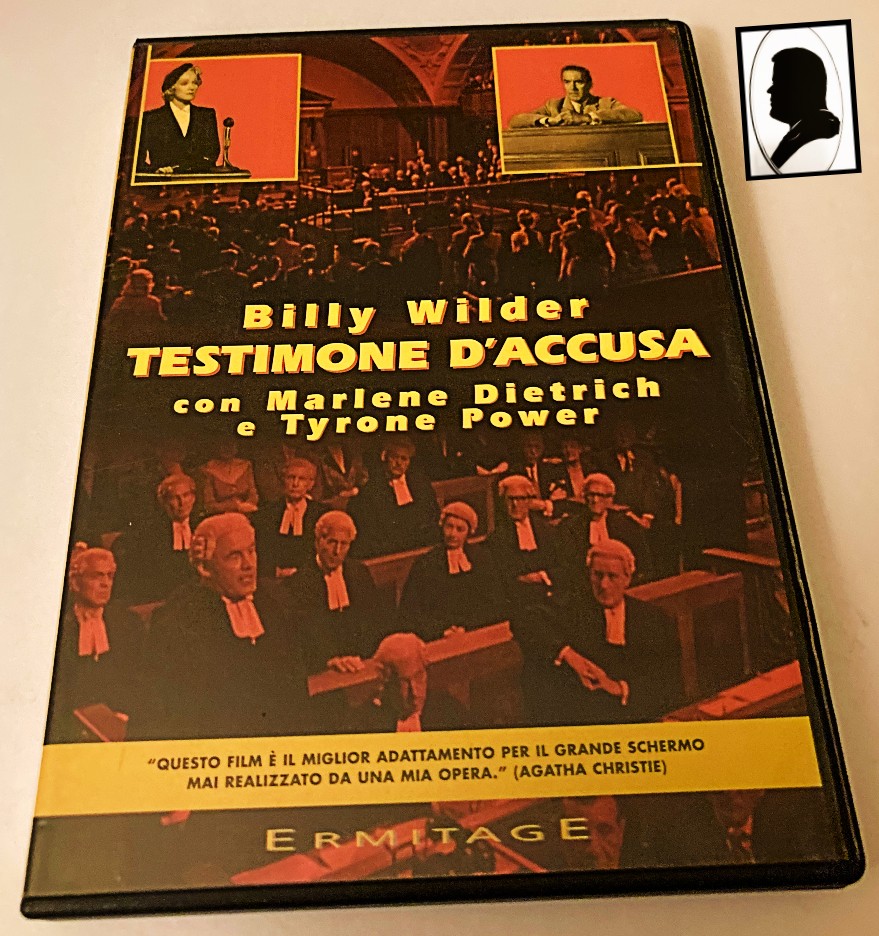(Italia, 1974)
Dino Risi e Ruggero Maccari scrivono la sceneggiatura del primo adattamento cinematografico dello splendido romanzo “Il buio e il miele”, scritto da Giovanni Arpino e pubblicato per la prima volta nel 1969.
I due grandi cineasti italiani apportano alcune piccole modifiche alla storia originale, come il nome del giovane militare che nel romanzo non viene mai citato o quella che riguarda il volto del protagonista: il capitano dell’esercito non vedente che nel romanzo è gravemente sfigurato, nel film ha invece quello splendido e tagliente di un Vittorio Gassman stratosferico, in una delle sue interpretazioni cinematografiche più famose di sempre.
Il giovane studente Giovanni Bertazzi (un bravo e sornione Alessandro Momo, alla sua ultima interpretazione perché, purtroppo, perirà poche settimane dopo la fine delle riprese in un incidente automobilistico guidando la motocicletta prestatagli dalla sua amica Eleonora Giorgi) sta per terminare il servizio di leva obbligatorio e il suo capitano gli affida un compito particolare che gli consentirà di godere di alcuni giorni di licenzia in più.
Deve assistere e accompagnare un ex militare che, quasi dieci anni prima, è rimasto cieco, perdendo anche una mano, per lo scoppio imprevisto di una granata durante una esercitazione. Il capitano Fausto Consolo (Gassman), che ha ormai quarant’anni e vive in solitudine in una grande casa nel centro di Torino assieme ad un’anziana cugina. Nonostante i facoltosi mezzi di cui dispone, intende compiere un viaggio in treno per raggiungere Napoli.
La prima sosta con pernotto verrà effettuata a Genova mentre la seconda a Roma. A Napoli lo aspetta il tenente Vincenzino (Franco Ricci) suo ex commilitone e compagno di disgrazia, visto che gli era accanto durante l’esplosione e anche lui ha perduto la vista.
Dal primo incontro Giovanni comprende che il capitano Consolo è un uomo molto difficile e complicato, non certo per la sua disabilità, ma per la rabbia e per il rancore con cui l’affronta. Rabbia e rancore che fin troppo spesso sfoga sugli altri e poi su se stesso, abusando di sigarette ed alcol.
Consolo gli impone di chiamarlo Ciccio, come ha fatto con i suoi attendenti temporanei precedenti, e i due partono per il viaggio come stabilito. Già dai primi attimi Consolo non fa che mettere in imbarazzo il giovane e tutti quelli che incontra ostentando il suo rancore con il mondo interno. Arrivati a Genova, l’ex capitano gli chiede di andare a studiare le prostitute nella via adiacente il loro albergo e di sceglierne una con alcuni requisiti ben precisi.
La notte i due dormono in camere comunicanti, Giovanni si accorge che il suo compagno di viaggio si è addormentato con la luce accesa. Mentre gliela sta spegnendo, intravede una rivoltella nascosta nella valigia, cosa che naturalmente lo mette in ulteriore agitazione. Il giorno dopo Fausto si fa accompagnare dalla prostituta (incarnata da Moira Orfei) e dopo l’incontro a pagamento rimprovera Ciccio per avergli mentito: non era lei quella che lui aveva individuato il giorno prima.
Arrivati a Roma, Fausto fa visita a suo cugino prete, che cristianamente accetta porgendo l’altra biblica guancia agli insulti e alle offese che come sempre l’ex militare gli rivolge. Nonostante le grandi differenze, il rapporto fra l’ex capitano ed il giovane Bertazzi diventa sempre più complice e prima di ripartire per Napoli, Ciccio decide di presentargli la sua ragazza. Dopo l’incontro Fausto gli aprirà gli occhi – …è proprio il caso di dirlo – su alcuni ambigui comportamenti della giovane che lui, nonostante una vista perfetta, non era mai riuscito ad individuare.
A Napoli i due vengono ospitati in casa di Vincenzino frequentata, oltre che dall’attendente ”temporaneo” dell’ex tenente (Sergio Di Pinto), da alcune ragazze che sono le figlie, a alcune relative amiche, della titolare della trattoria non troppo lontana, dove il padrone di casa è solito consumare i pasti.
Fra queste c’è Sara (Agostina Belli, che grazie a questo ruolo verrà consacrata a stella del nostro cinema) che, poco più che adolescente, è da sempre innamorata di Fausto, che invece la rifiuta e l’allontana umiliandola tutte le volte. Il vero scopo del viaggio, Fausto lo ha tenuto nascosto a tutti, tranne che a Vincenzino che anche in questo frangente sarà suo triste complice…
A distanza di cinquant’anni questa pellicola possiede integra tutta la sua potenza narrativa ed il suo fascino struggente e disperato, soprattutto grazie a un Vittorio Gassman stratosferico ed indimenticabile, che sembra proprio quello uscito dalle pagine del libro di Arpino. Una riflessione dolorosa e melanconica sulla vita e su come bisognerebbe affrontarla e su come, invece, alla fine la si riesce ad affrontare.
Il successo del film supera i nostri confini, facendogli conquistare numerosi premi fra i quali il César in Francia come miglior film straniero e il premio a Vittorio Gassman come miglior attore al Festival di Cannes. Inoltre, colleziona prestigiose candidature come quella alla Palma d’Oro sempre a Cannes di Risi, e agli Oscar sia come miglior film straniero che come migliore sceneggiatura non originale per Risi e Maccari.
Nel 1992 Martin Brest dirige “Scent Of A Woman – Profumo di donna”, adattato per il grande schermo da Bo Goldman e ispirato al film di Risi e al romanzo di Arpino. A parte la grande interpretazione di Al Pacino – che vince l’Oscar – nel ruolo che fu di Gassman, la pellicola americana non sfiora lontanamente le vette di questa diretta da Risi.