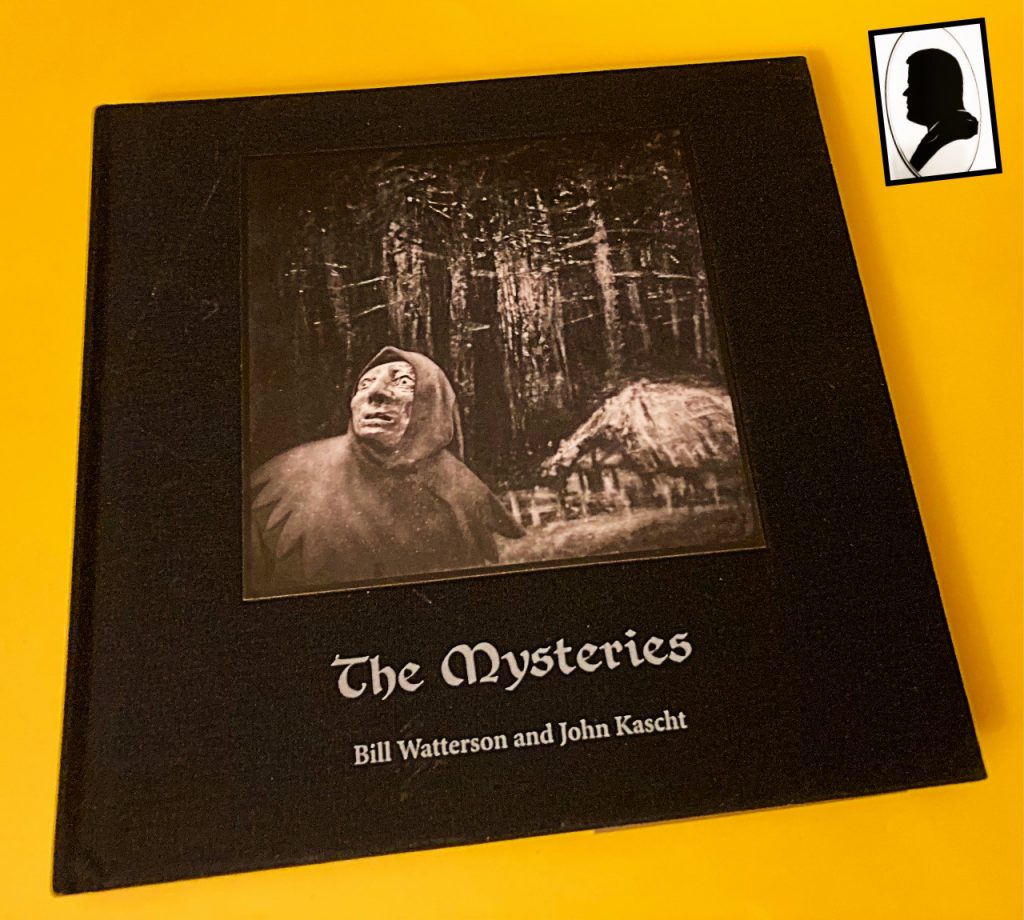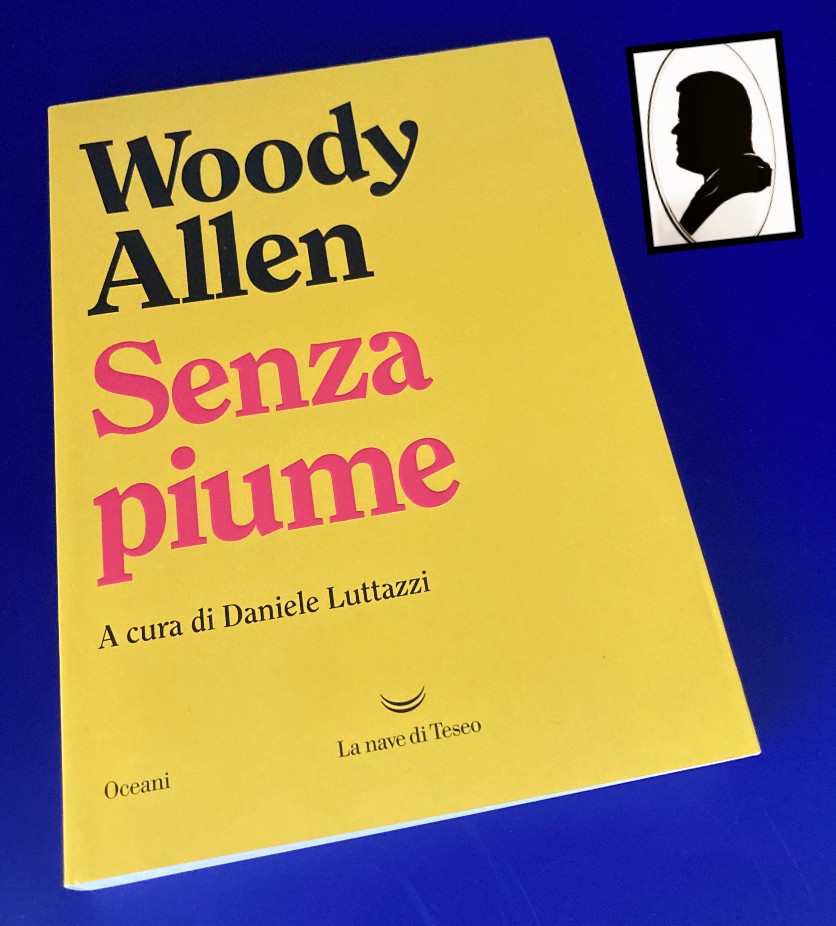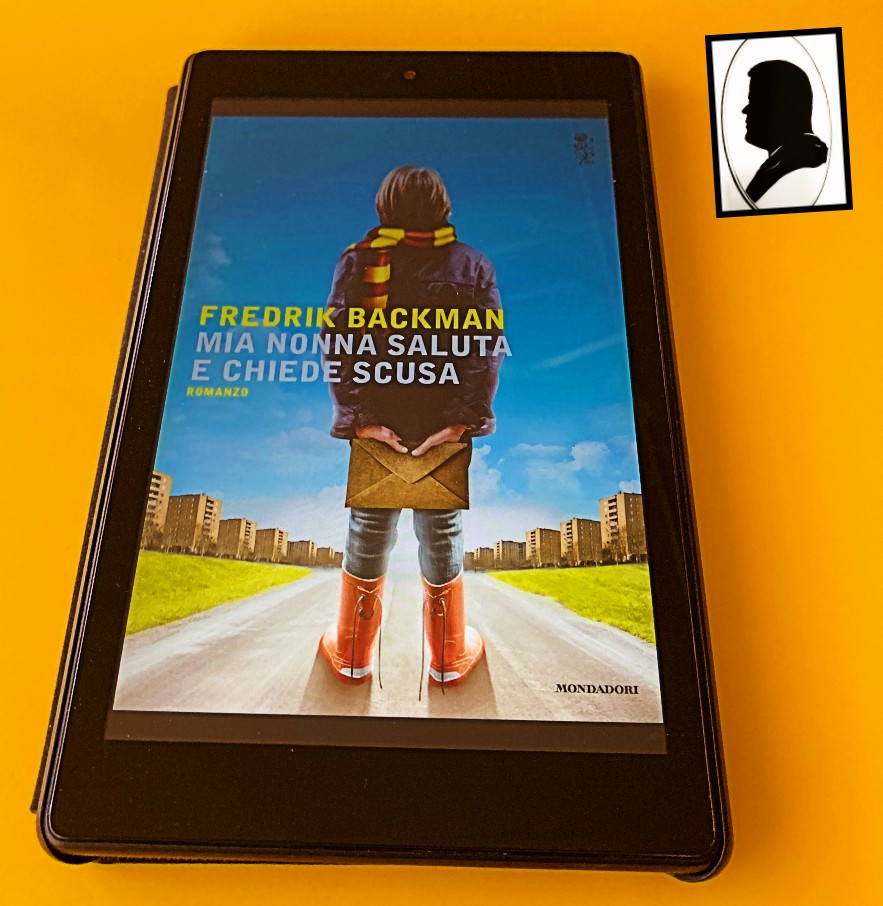(Italia/Francia, 2023)
L’immenso stabilimento Ilva di Taranto, uno dei più grandi centri siderurgici d’Europa inaugurato definitivamente nel 1965, da fiore all’occhiello della nostra grande industria dell’epoca d’oro del Boom economico, nel corso degli ultimi decenni si è trasformato in uno dei più grandi problemi sociali, sanitari ed economici del nostro Paese.
La medicina e la scienza hanno dimostrato, purtroppo, come l’acciaieria abbia causato gravissimi e spesso inesorabili danni alla salute non solo alle lavoratrici ed ai lavoratori dello stabilimento stesso, ma anche a quella delle cittadine e dei cittadini della limitrofa Taranto. Intanto, la situazione dei dipendenti dell’Ilva subisce un indiscriminato peggioramento a metà degli anni Novanta, quando il nostro Paese inizia a privatizzare le sue più grandi aziende nazionali.
Nel grande patrimonio di società statali creato dai nostri governi a partire dal secondo dopoguerra – patrimonio che ci permise di diventare negli anni Sessanta la settima potenza industriale del pianeta – che dal 1992 è stato messo in vendita c’è anche l’Ilva, che si ritrova così ad avere dall’oggi al domani una proprietà privata che, come accade fin troppo spesso, per aumentare i ricavi e limitare le spese, per prima cosa inizia a mettere in discussione alcuni fondamentali diritti dei lavoratori.
Taranto, 1997. All’llva lavora come operaio Caterino Lamanna (Michele Riondino), nipote di uno dei dirigenti storici dello stabilimento. Per Caterino il cambio di proprietà non ha voluto dire nulla anzi, poco condivide le proteste che alcuni suoi colleghi minacciano ogni giorno visto il numero sempre più rilevante di incidenti, spesso mortali, che si consumano nello stabilimento.
Così Lamanna viene avvicinato dal dottor Giancarlo Basile (un bravissimo Elio Germano), alto dirigente che ha il compito di riordinare la società per renderla più “snella ed efficiente”. Basile, con la scusa di parlare dello zio di Caterino con il quale lui ha lavorato da giovane, gli chiede di tenerlo informato sugli umori e soprattutto sulle intenzioni dei lavatori in relazione alla nuova riorganizzazione.
Per incoraggiarlo e dimostrargli fiducia, Basile gli assegna anche un’automobile aziendale. Lamanna inizia così a diventare gli occhi e le orecchie di Basile, scoprendo che il delegato sindacale Renato Morra (Fulvio Pepe) si sta rivolgendo ad un avvocato specializzato nel Diritto del Lavoro.
Morra va spesso nella Palazzina Laf – che è l’acronimo di “Laminatoio a freddo” – che molti considerano il “rifugio” dei dipendenti scansafatiche dell’Ilva. Lamanna allora chiede a Basile di essere trasferito proprio lì, in quello che molti considerano il paradiso dei privilegiati. Ma Caterino, nonostante i suoi grandi limiti difficili da superare a causa soprattutto della sua indolenza e dei suoi pregiudizi, alla fine comprenderà che la Palazzina Laf più che il Paradiso è l’Inferno dei lavoratori dell’Ilva, che la nuova dirigenza considera scomodi e che vuole riassegnare in posti lontani o opposti alle loro peculiari competenza proprio per renderli pesi morti, anche agli occhi dei colleghi…
Riondino, al suo esordio dietro la macchina da presa, ci racconta gli eventi che portano la Magistratura italiana ad indagare su quello che ancora oggi è considerato uno dei casi di mobbing più gravi della nostra storia repubblicana. Grazie anche alle ottime interpretazioni di Riondino e Germano, alla sceneggiatura scritta dallo stesso Riondino assieme a Maurizio Braucci, riviviamo uno dei drammi lavorativi più rilevanti della nostra storia recente, e di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze.
La – troppo spesso frenetica – privatizzazione delle nostre grandi aziende, a distanza di circa trent’anni, non ha reso il nostro Paese più agile e più competitivo – come …qualcuno… prometteva allora – ma lo ha fatto diventare soprattutto più povero, arricchendo solo una manciata di “eletti” individui col passaporto italiano, oltre che rimpinguare la casse di varie società straniere.