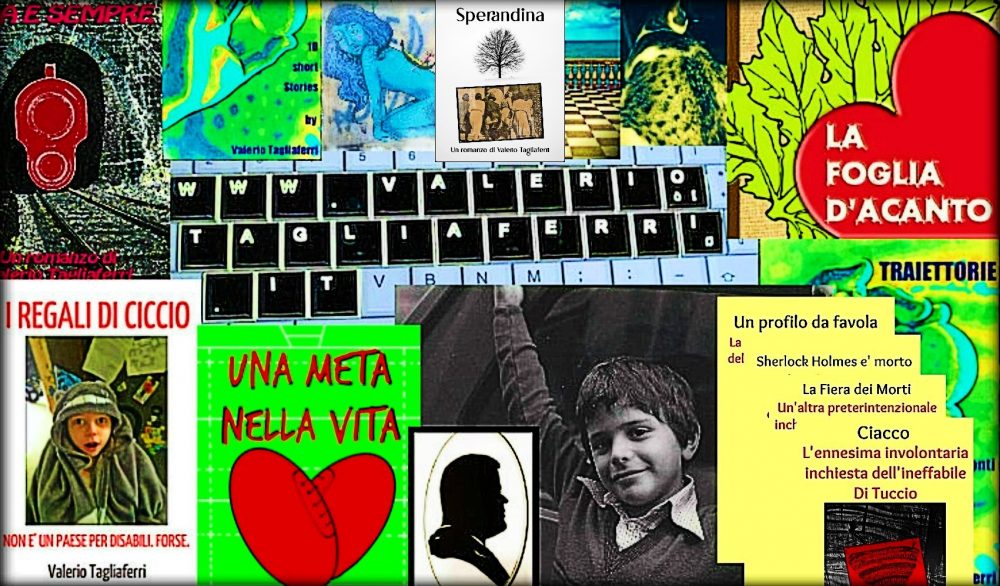(USA, 1964)
Sol Nazerman (un indimenticabile Rod Steiger) gestisce un banco dei pegni in uno dei quartieri più popolari di New York: Harlem.
Per la sua indole fredda e distaccata riesce ad approfittarsi al meglio dei disperati che entrano nel suo negozio. Sol, infatti, non prova più niente. Da quando, unico della sua famiglia, è tornato dai campi di sterminio nazisti, le sue emozioni sono letteralmente sparite.
Solo Jesus, il giovane commesso portoricano che lo aiuta nella sua attività, sembra riuscire ad avvicinarlo. E quando questo, per proteggerlo, cade sotto i colpi di un rapinatore, Sol decide di tornare a “sentire”…
Tratto dal romanzo di Edward Lewis Wallant e con le musiche di Quincy Jones, “L’uomo del banco dei pegni” è uno delle opere più emozionanti che il cinema ha dedicato all’Olocausto.
L’uscita della pellicola negli Stati Uniti suscitò numerose polemiche soprattutto per le scene di nudo di donna – allora inconcepibili in un film “drammatico” per il grande pubblico – e per gli stereotipi con cui, secondo alcuni, vennero ritratti gli afroamericani e i latinoamericani come i “soliti” criminali, e gli ebrei come i “soliti” strozzini.
Se la sceneggiatura del film forse possiede alcune lacune, è giusto ricordare la splendida interpretazione di Steiger e la riuscita di alcune scene indimenticabili come quella del flashback di Sol che viene quotidianamente straziato dal ricordo della morte del piccolo figlio che, sul vagone piombato che li stava portando in un campo di sterminio dopo infiniti giorni in piedi senza acqua né cibo e stretto agli altri deportati, non lo riesce più a tenere sulle spalle e lo lascia inesorabilmente cadere sul pavimento dove verrà inghiottito dal buio per sempre.
Così come quella in cui sempre Sol, davanti al cadavere di Jesus, disperato dal non provare più emozioni sbatte la mano volontariamente sul chiodo ferma bollette che ha sul bancone per tornare, almeno per qualche istante, un vero essere umano.
Una pellicola dura e tragicamente indimenticabile che è giusto riguardare di tanto in tanto, sia per ricordare tutti quelli che dai campi di sterminio non sono tornati, sia per mantenere bene in mente cosa accadde, chi lo fece, chi si oppose e chi, purtroppo, voltò lo sguardo da un’altra parte perché, come disse la maestra alla piccola Liliana Segre: “…le leggi razziali non le ho fatte io!”.