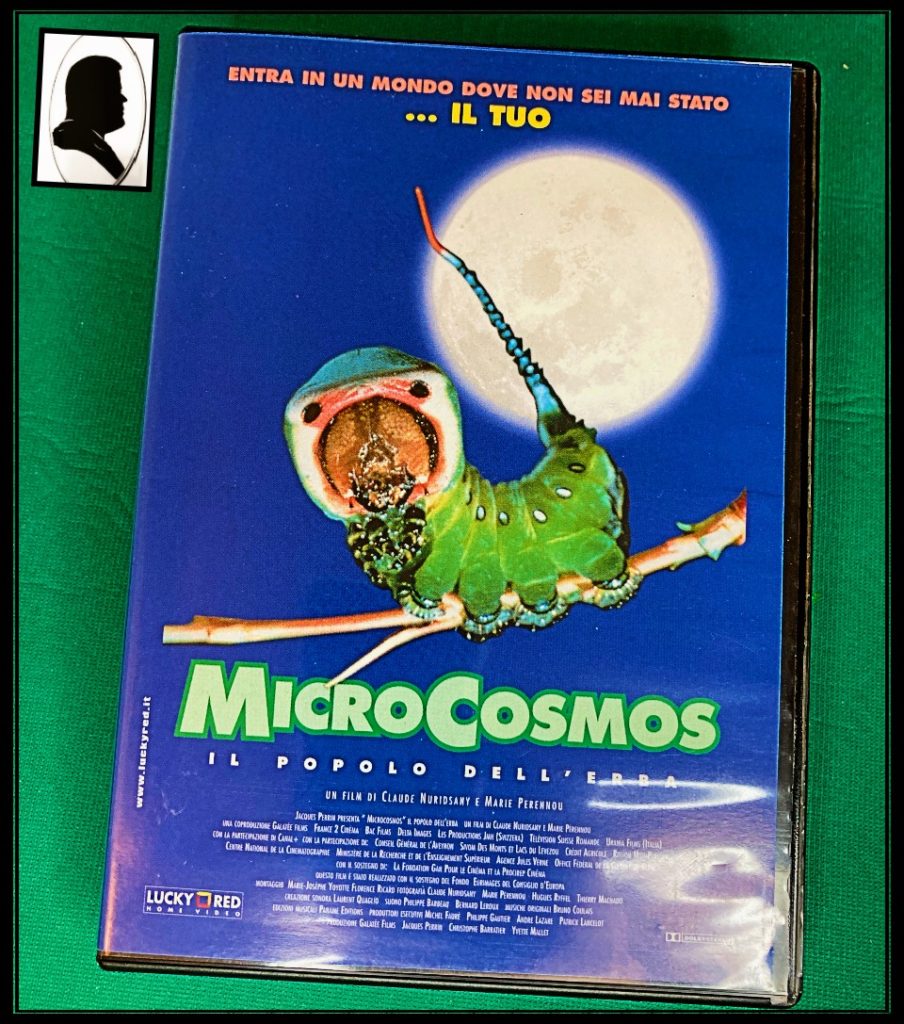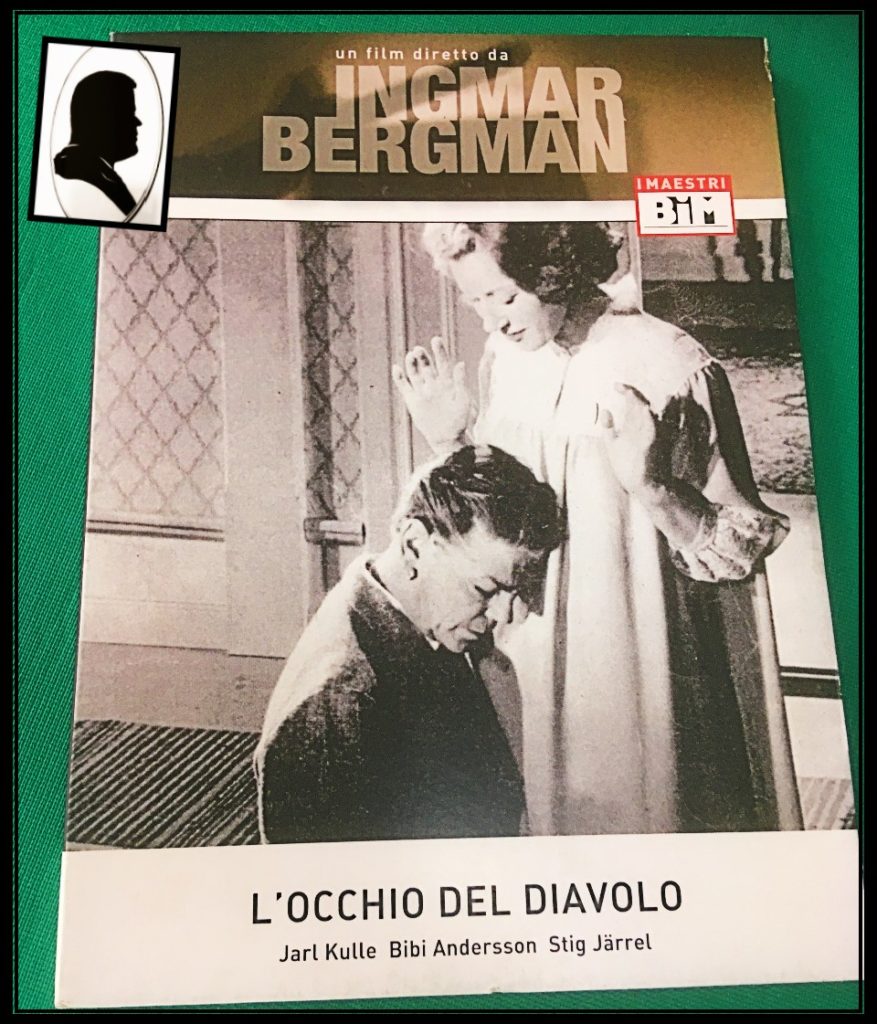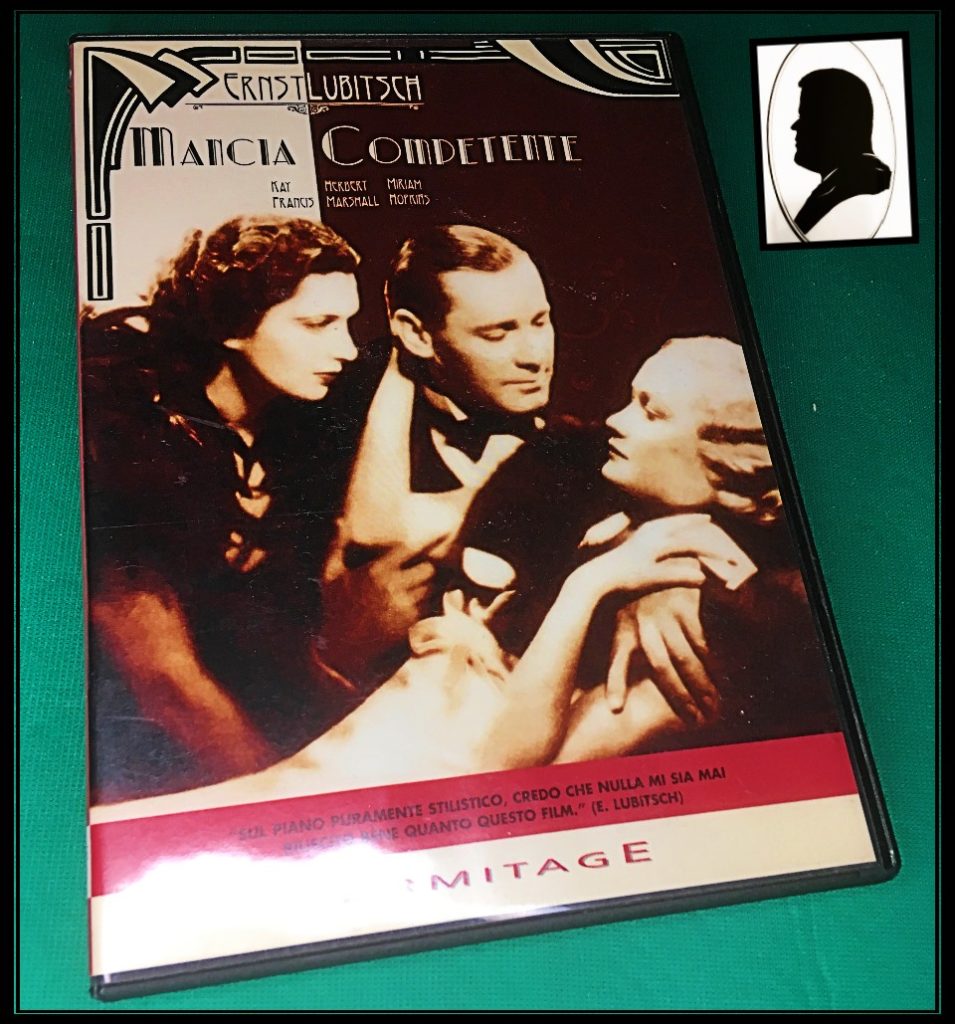(Giappone, 1969)
Poco più di dieci anni dopo l’uscita nella sale giapponesi dello splendido “La leggenda del serpente bianco“, il primo anime nella storia del cinema, la Toei Animation realizza il suo quindicesimo lungometraggio.
Così come per il primo, ispirato ad un’antica leggenda cinese, anche per questo la società di produzione prende spunto da una fiaba fuori dalle tradizioni giapponesi, cosa che le consente di ampliare il mercato di distribuzione.
Viene scelta “Il gatto con gli stivali” del francese Charles Perrault, alla quale gli sceneggiatori Hisashi Inoue e Morihisa Yamamoto uniscono spunti ed elementi tipici dei romanzi immortali del maestro Alexandre Dumas. Al gatto protagonista viene dato il nome Pero – senza accento – proprio in onore del suo creatore.
Assistiamo all’imponente processo felino nel quale Pero viene condannato a morte dai suoi simili perché ha lasciato fuggire vivo e vegeto un topo. Ma Pero è così: ama la giustizia e la vita. Così, ascoltata la condanna alla pena capitale, saluta tutti col suo cappello e fugge via grazie alla sua scaltrezza e alla sua spada.
Sulle sue tracce vengono inviati tre maldestri gatti sicari, tra cui il più imbranato è Gattognan, che però non riescono mai a prenderlo. Intanto Pero s’imbatte casualmente nel povero e cortese Pierre, giovane contadino vittima dei suoi fratelli maggiori che gli hanno portato via tutto.
Grazie al suo ingegno Pero riesce a far incontrare Pierre con la bella principessa Rosa che, suo malgrado, è al centro delle attenzioni del perfido e malefico Re Lucifero. Ma Pero non si lascia intimidire dai suoi nefasti poteri magici…
Ottanta minuti di ottimo cinema d’animazione, con trovate e gag molto divertenti, conditi da musiche e canzoni scritte apposta per il film. Il successo è planetario tanto da portare la stessa Toei Animation ad adottare Pero come mascotte usando il suo ritratto stilizzato nel proprio logo, e ha mettere in cantiere vari sequel.
Al di là del fatto che questa pellicola è una delle più care della mia infanzia, anche perché veniva trasmessa a ripetizione da un’emittente privata romana alla fine degli anni Settanta, possiede due rilevanti elementi in comune col grande cinema d’animazione che l’ha preceduta e con quello che la seguirà.
Infatti non è casuale il richiamo a “Puss in Boots”, uno dei primi cortometraggi realizzati da Walt Disney nel 1922. Inoltre nel cast tecnico, fra gli animatori, ci sono Hayao Miyazaki e Yasuo Ôtsuka. I due collaboreranno molto insieme, soprattutto nei decenni successivi in serie televisive come “Le avventure di Lupin III” e “Il fiuto di Sherlock Holmes” dirette dallo stesso Miyazaki.
Ma soprattutto Ôtsuka parteciperà alla realizzazione di “Lupin III: Il castello di Cagliostro” primo lungometraggio animato diretto da Miyazaki, in cui alcune scene spettacolari si ispirano esplicitamente a quelle animate dai due dieci anni prima ne “Il gatto con gli stivali”, relative all’inseguimento di Rosa e Pierre da parte di Lucifero sulla torre del suo oscuro castello. Anche la scena finale ricorda molto quella conclusiva de “La ricompensa del gatto“.
Un lungometraggio d’animazione davvero particolare, che in Italia venne presentato all’apertura del Salone Internazionale dei Comics di Lucca del 1969.